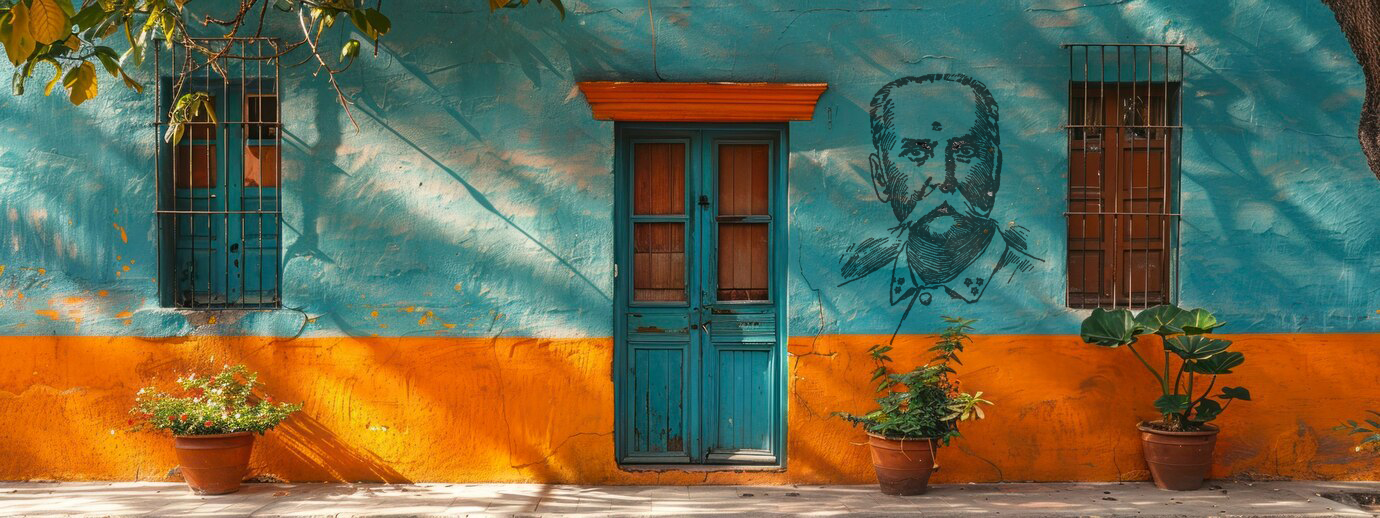Un frenetico turbinio di emozioni assale Riley quando scopre che i genitori vogliono lasciare la campagna dove è cresciuta per trasferirsi in città. Avverte rabbia mista a paura, tristezza e persino disgusto, perché si sente impotente di fronte a un cambiamento che non ha scelto. La sua vita, fino a quel momento serena e gioiosa, sembra sul punto di trasformarsi radicalmente, lasciandola smarrita. Non sa cosa fare, ma non ha scelta: i genitori hanno già deciso.
Inizia così la sua personale guerra contro il mondo. Travolta da un vortice emotivo incontrollabile, prende la decisione più istintiva: fuggire dagli eventi. Decide di lasciare la città e i genitori per tornare alla campagna, nella speranza di recuperare il suo paradiso perduto.
Ma proprio quando pensa di aver trovato la soluzione, mentre percorre la strada verso la stazione dei pullman, una sensazione di tristezza la invade. Emergono nuovi dubbi: sta davvero facendo la cosa giusta? Ritroverà la felicità? Riuscirà davvero a ricostruire da sola il suo mondo ideale?
La felicità per la fuga si trasforma in paura di sbagliare, in rabbia per l’incertezza. Poi, improvvisamente, un pensiero inaspettato si fa strada dentro di lei. Rallenta il passo, accenna un timido sorriso che pian piano si allarga sul volto. Si ferma e cambia idea: decide di tornare indietro.
Il suo puzzle interiore si ricompone sotto una nuova luce. Cosa è successo? Riley ha superato il proprio tsunami emotivo e ha imparato a vedere opportunità dove prima vedeva solo ostacoli. Ha accettato il cambiamento, combinando emozioni contrastanti e lasciandole fluire senza giudicarle. In questo processo, ha scoperto che anche la tristezza, spesso etichettata negativamente, può avere un ruolo positivo, permettendole di maturare una nuova visione.
Il film Inside Out offre una potente metafora sul ruolo determinante delle emozioni in ogni fase della nostra vita. Senza scomodare studiosi come Ekman, Friesen, Lange, Cannon o Goleman, è interessante riflettere su come le emozioni si intreccino con aspetti culturali, sociali e linguistici, dando origine a nuove sfumature emotive.
Uno degli aspetti più affascinanti di questo processo è la granularità emotiva, un’abilità che si sviluppa affinando la sensibilità emotiva e linguistica. Riuscire a riconoscere le sottili differenze tra emozioni simili permette di avere una maggiore consapevolezza di sé. Siamo sempre semplicemente tristi, o a volte ci sentiamo frustrati, sconsolati, disperati? Siamo solo arrabbiati, o proviamo disappunto, irritazione, esasperazione? Esiste una differenza tra paura e angoscia?
La combinazione tra emozioni e linguaggio diventa uno strumento fondamentale per comprendere con maggiore precisione ciò che proviamo. Non si tratta solo di arricchire il nostro vocabolario, ma di sviluppare la capacità di dare un nome specifico alle nostre emozioni, così da riconoscerle e gestirle meglio. Proprio come i colori hanno diverse tonalità, anche le emozioni hanno infinite sfumature.
La granularità emotiva non è un dono innato, ma una competenza che si può allenare. Lavorando sia sulla consapevolezza emotiva che su quella linguistica, possiamo sviluppare una maggiore padronanza delle nostre reazioni e rispondere in modo più equilibrato alle situazioni, senza lasciarci sopraffare. Studi dimostrano che chi possiede un’elevata granularità emotiva sviluppa una maggiore resilienza e affronta le difficoltà con più lucidità.
Ma c’è di più: le nuove emozioni possono essere qualificate con parole prima inesistenti. In diverse culture, infatti, esistono termini specifici per descrivere emozioni raffinate e granulari. In Galles, ad esempio, esiste la parola “hwyl“, che indica la leggera euforia che si prova quando si è in compagnia. In Francia, baxoresia descrive il bisogno improvviso di baciare qualcuno. Gli Inuit della Groenlandia usano iktsuapork per indicare l’impazienza di aspettare qualcuno. In Spagna, verguenza ajena esprime l’imbarazzo provato per conto di qualcun altro. E questi sono solo alcuni esempi.
L’aspetto sorprendente è che non solo il linguaggio nasce per descrivere nuove emozioni, ma le parole stesse possono generare emozioni inedite. Ogni lingua riflette valori, credenze e abitudini della cultura che la esprime, e proprio per questo la scelta delle parole incide sulla nostra esperienza emotiva.
Secondo Daniel Goleman, per sviluppare una vera intelligenza emotiva è essenziale comprendere il significato profondo delle parole, andando oltre il semplice vocabolario. In fondo, le parole che scegliamo non solo descrivono il nostro mondo interiore, ma lo modellano.
E così, il nostro viaggio alla scoperta delle emozioni potrebbe non finire mai…
“Il linguaggio, prima di significare qualcosa, significa per qualcuno”.
Jacques Lacan